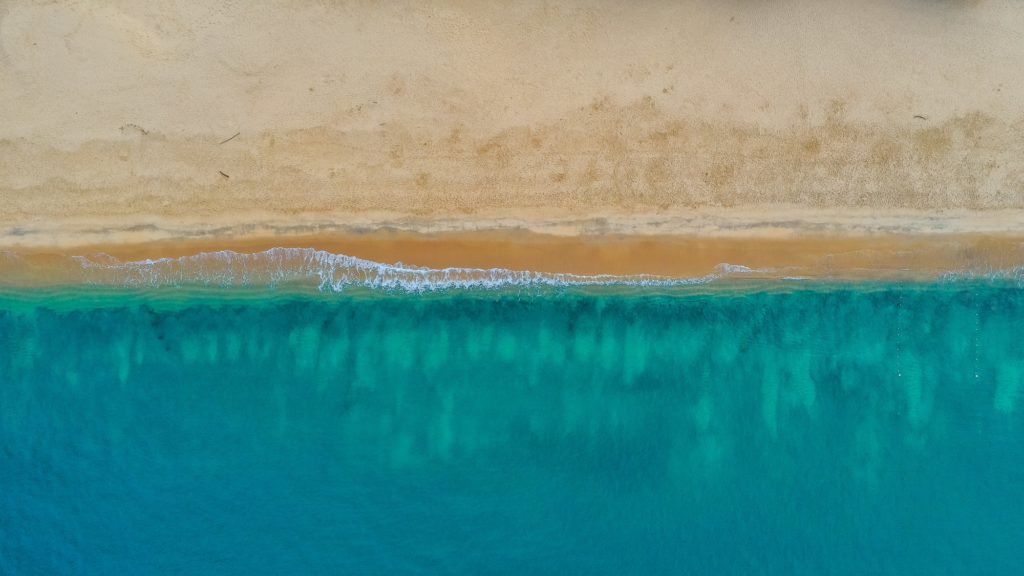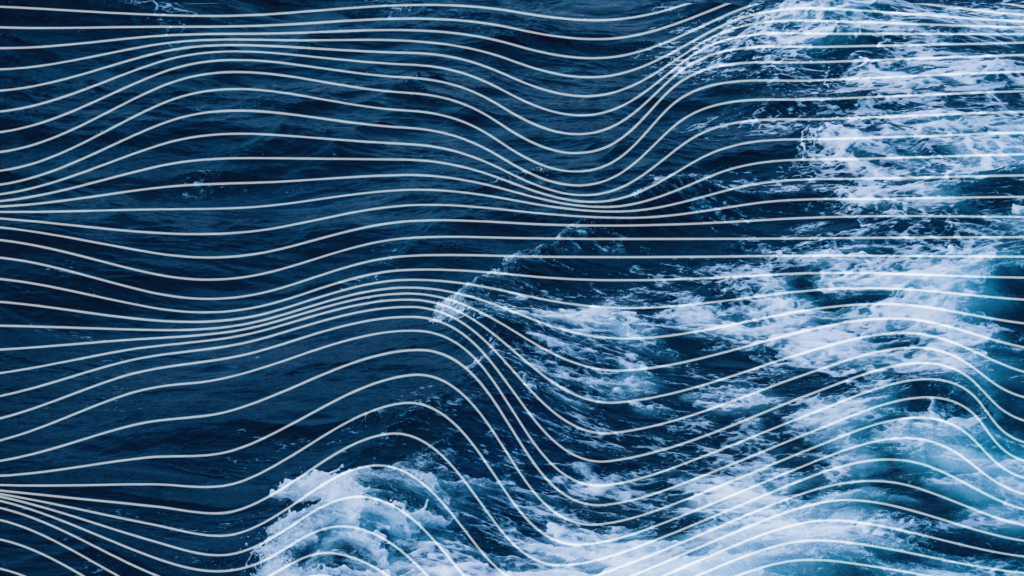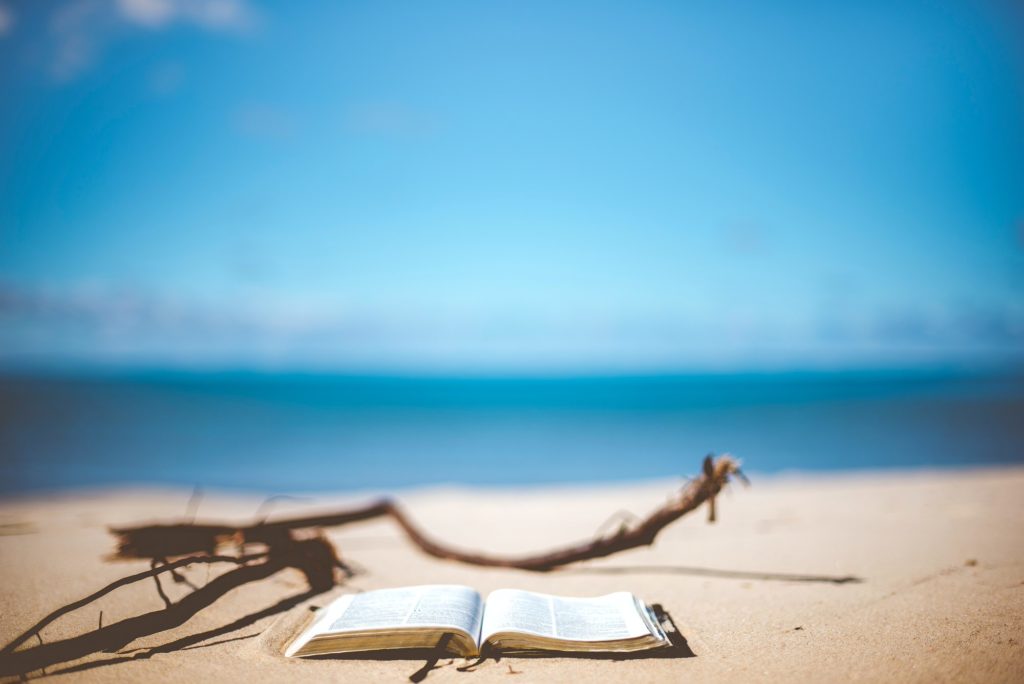Lunedì 19 giugno 2023, i 193 Stati Membri delle Nazioni Unite hanno formalmente adottato il Trattato dell’Alto Mare volto a proteggere la biodiversità oltre i confini nazionali, fino ad ora minacciata da inquinamento, crisi climatica e pesca eccessiva.
Ci sono voluti più di due decenni di negoziati per trovare un’onda comune per riuscire a regolamentare le attività e la preservazione della biodiversità marina nelle zone di alto mare, oltre le zone di giurisdizione nazionale.

Le zone considerate “Alto Mare” ricoprono circa il 70% della superficie dell’oceano e circa il 95% del suo volume, ospitando così gran parte della biodiversità marina. Il nuovo accordo va ad agire per contrastare le tre crisi planetarie in atto – climatica, perdita di biodiversità e inquinamento – e invertire il trend di deterioramento dell’ambiente.
“Abbiamo un nuovo strumento. Questo risultato storico testimonia l’impegno collettivo per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale. Insieme, avete gettato le basi per una migliore gestione dei nostri mari, garantendo la loro sopravvivenza per le generazioni a venire”.
Csaba Kőrösi, Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Perché è importante il Trattato dell’Alto Mare?
Il Trattato sull’Alto Mare, o Trattato sulla Biodiversità Oltre le Zone di Giurisdizione Nazionale, offre un quadro aggiornato alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), entrata in vigore nel 1994. Il nuovo accordo considera l’oceano in tutti i suoi aspetti, valutando la sua importanza nei diversi settori, dall’economia alla regolazione del clima, perdita di biodiversità e inquinamento.
In un periodo in cui c’è un forte aumento di interesse per l’esplorazione e l’utilizzo delle risorse marine delle acque di altura, il trattato mira anche ad aumentare e regolamentare la condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse in modo giusto ed equo.
Questo è anche un importante passo per raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dal Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework per la conservazione della biodiversità.

“L’oceano è la linfa vitale del nostro pianeta e oggi avete dato nuova vita e speranza per dare all’oceano una possibilità di combattere”
António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite
Cosa cambia in termini di governance?
Per decenni, le zone di alto mare sono state governate senza considerare le nuove necessità e sfide emerse negli anni.
Molte attività sono regolamentate da diversi accordi e trattati, come il trasporto marittimo, la pesca e le attività estrattive. Ma questi accordi e convenzioni hanno dialogato molto poco tra loro, lavorando in compartimenti stagni e creando assenza di coerenza e coordinamento.
Questa governance frammentata e incoerente è risultata in un sistema inadeguato per gestire e contrastare il degrado ambientale, la crisi climatica e la perdita di biodiversità. Tre crisi che richiedono azioni collettive e coordinate a livello globale.
Grazie all’adozione del Trattato di Alto Mare si accede ad un nuovo quadro di riferimento che offre nuovi strumenti e meccanismi di governance e azione per la conservazione, l’uso e la gestione delle risorse marine.
1. Nuove azioni di protezione oltre i confini nazionali
Il Trattato dell’Alto Mare ha l’obiettivo di portare gli Stati ad assumere la gestione dell’oceano per conto delle generazioni presenti e future, in linea con gli articoli e obiettivi presenti nella Convenzione sul Diritto del Mare (UNCLOS).
Grazie all’adozione del trattato, anche le zone di alto mare hanno acquisito nuove forme di protezione da impatti come l’inquinamento e la pesca eccessiva. Il nuovo accordo contiene 75 articoli che hanno lo scopo di proteggere, prendersi cura e garantire l’uso responsabile dell’ambiente marino, mantenere l’integrità dei suoi ecosistemi e preservare il valore intrinseco della diversità biologica.
L’accordo consentirà di istituire strumenti di gestione basati sulle aree, comprese le aree marine protette, per conservare e gestire in modo sostenibile habitat e specie vitali in alto mare e nell’area dei fondali marini internazionali. L’obiettivo? Tutelare almeno il 30% dell’oceano entro il 2030.

2. Un oceano più pulito
Sostanze chimiche tossiche e milioni di tonnellate di rifiuti vengono riversati quotidianamente negli ecosistemi costieri, provocando ingenti danni agli habitat e alle specie che li abitano, entrando nella catena alimentare e arrivando così fino a noi.
Secondo l’ultimo rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), nel 2021 più di 17 milioni di tonnellate di plastica sono entrate nell’oceano, costituendo l’85% dei rifiuti marini. I modelli previsionali stimano che la quantità raddoppierà o triplicherà ogni anno entro il 2040.
Prima di mettere in atto azioni nell’alto mare, gli Stati dovranno valutare i potenziali impatti ambientali di qualsiasi attività pianificata al di fuori delle loro giurisdizioni.
In aggiunta, sul fronte inquinamento, le Nazioni Unite hanno avviato una negoziazione per un nuovo trattato globale per porre fine all’inquinamento da plastica. Si tratta di un passo storico per proteggere la fauna selvatica, l’ambiente e l’umanità dagli effetti nocivi dell’inquinamento derivante da questi materiali.

3. Gestione sostenibile degli stock ittici
Secondo le Nazioni Unite, più di un terzo degli stock ittici mondiali è sovrasfruttato. Questo significa che la disponibilità di risorse ittiche diminuisce anno dopo anno.
Il Trattato dell’Alto Mare sottolinea l’importanza di collaborare per aumentare e rafforzare le capacità e trasferire tecnologie innovative, compreso lo sviluppo delle capacità istituzionali e dei quadri o meccanismi normativi nazionali. Per raggiungere l’obiettivo bisogna lavorare per raggiungere una maggiore collaborazione tra le organizzazioni marittime regionali e le organizzazioni regionali di gestione della pesca.


4. Contrastare la crisi climatica
La crisi climatica riguarda anche l’oceano. L’aumento della temperatura media dell’oceano alimenta lo sviluppo di tempeste rendendole sempre più frequenti e intense. Non solo, contribuisce a velocizzare il fenomeno di innalzamento del livello del mare legato all’espansione termica dell’acqua e allo scioglimento dei ghiacciai terrestri. Questo comporta l’aumento di fenomeni di erosione costiera, alluvione e inondazione di centri abitati e grandi metropoli e la salinizzazione delle terre e delle falde acquifere, diminuendo così la quantità di acqua dolce disponibile.
Per rispondere a queste urgenti preoccupazioni, il Trattato dell’Alto Mare offre una guida per lavorare ad aumentare la resilienza degli ecosistemi mantenendo e ripristinando la loro integrità. Azioni di protezione e rigenerazione contribuiscono anche ad affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico.
Le disposizioni del Trattato dell’Alto Mare inoltre riconoscono anche i diritti e il valore delle conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene e delle comunità locali, la libertà della ricerca scientifica e la necessità di una giusta ed equa condivisione dei benefici, come già riportato anche in UNCLOS.


Data: Berkeley Earth, NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD, SMHI, UoR & ZAMG
Sources: